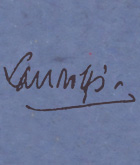Autoantologia landolfiana – Quattro contributi
di ANTONIO PRETE
La piccola silloge che qui si propone offre un quadro d’insieme complesso della figura di Tommaso Landolfi. Quasi a ricostruire le tappe di un dialogo tra l’autore e il suo lettore d’eccezione, Antonio Prete, questi scritti eterogenei sono accomunati da un’identica, appassionata volontà interpretativa.
COSMOGRAFIE LANDOLFIANE
Fisica e metafisica lunare
La cosmografia dei romantici dava allo stupore uno sfondo metafisico, trasformando la contemplazione in interrogazione ultima: il notturno lunare era il teatro di una esplorazione dell’interiorità o, come accadeva meravigliosamente in Leopardi, lo spazio scenico di una meditazione sulla transitorietà dell’uomo e delle cose. Acquisto di un punto di estrema lontananza dal quale osservare l’insignificanza del mondo. La cosmografia di Landolfi accoglie la tensione metafisica e interrogativa delle poetiche romantiche, ma ne svolge, amplificando fino alla consapevole maniera e all’artificio, la tessitura ironica, teatralmente grottesca, e insieme perturbante. Un dialogo assiduo con la cosmografia leopardiana agisce nella scrittura di Landolfi. E infatti la leopardiana oscillazione, o meglio tensione, tra affabulazione e parodia, tra modi fantastici e ansia metafisica diventa in Landolfi la misura di uno stile e di una ricerca. Per questo il giudizio del Signor Giacomo Leopardi è messo in scena, con una filosofica mimesi di scrittura, in appendice alla Pietra lunare, il bellissimo racconto del ’37. La luna landolfiana è osservata, leopardianamente, nella sua ambivalenza: divina e familiare, enigmatica e prossima, sovrana e compagna. È su questo sfondo che prende forma la dimensione ctonia, oscura, dell’elemento lunare. La sovranità pensosa e amicale della luna leopardiana nella Pietra lunare è in certo senso umanizzata e insieme animalizzata, cioè è portata verso la terrestrità corporea dell’amore. Gurù è certo una creatura lunare, che si muove in relazione costante con il sorgere e tramontare della luna, ma è anche, come in un teatro gnostico, emanazione corporea della divinità lunare. Figura della compresenza di luce e oscurità che è propria della luna: angelo e demone. La rappresentazione del fantastico, da Poe a Hoffmann a Gautier a Dostoevskij a Maupassant – è questa una sezione della biblioteca landolfiana – ha sempre mostrato l’estraneo come familiare, il misterioso come prossimo e transitabile: l’effetto, freudianamente, come ormai diciamo, della perturbante compresenza diventa elemento di tensione propria del fatto narrativo. La luce lunare di Landolfi non vela e rivela le cose, come quella leopardiana, non è, contemporaneamente, nascondimento e rivelazione, ma è una luce per così dire “maladive” – analoga in questo al profumo dei baudelairiani Fiori del male – e per questo avvolge le cose, come accade nel racconto L’impero della luna (nel Principe infelice) in un bagliore di diamanti che però è come una grande nebbia: tutto è irreale in quello scintillio d’alabastro, in quell’abbaglio vitreo, e gli abitanti sono malati di chiardiluna. Maladive è la luce lunare, ma quella solare può essere mortale: nel racconto Colpo di sole l’abbaglio della luce che sopravviene è descritto dal punto di vista della civetta, che via via, dissipandosi l’oscurità, è invasa da nausea e malinconia e strazio finché non “sprofonda nella luce bianca della morte”.
La luna in Landolfi è emblema notturno del femminile, o meglio del notturno che è costitutivo del femminile. Il volto lunare rinvia al volto femminile. Sia la ragazza-capra Gurù sia la ragazza di un racconto pubblicato sul “Corriere della sera” – La luna, le piene – hanno la dimensione teofanica propria dell’elemento lunare, e agiscono con la loro apparizione su chi è a loro prossimo, smuovendo dall’oblio sopite e turbate immagini. L’incarnazione lunare acquista sì il carattere e lo splendore della bellezza, ma si tratta di una bellezza mai soltanto abbagliante, spesso invece venata di oscuri presagi, di torbidi indecifrati enigmi. E c’è anche, nell’affabulazione lunare di Landolfi, un’altra faccia della luna, quella nascosta, una faccia che presiede al “rovescio delle cose”, a tutto quello che interviene, inatteso, a scombinare progetti, previsioni, a intorbidare i pensieri, insomma a scompigliare l’ordine temporale delle cose. “Dar di volta alla luna”: l’espressione risale, dice Landolfi, all’ “avviso di quell’antico astronomo che stimava essere la faccia della luna cava (egli anzi inferiva che ciò sarebbe servito un giorno alle potenze celesti per incenerirci, rivolgendosi l’astro su se stesso e ardendo a mo’ di specchio ustorio l’intero nostro globo)”. Già nel titolo il racconto Voltaluna dichiara l’azione di rivolgimento e di conturbante scompiglio.
Ma anche l’altra faccia della luna, quella esposta allo sguardo dell’uomo, è, nell’affabulazione fantastica landolfiana, fonte di disagio: “Una luna scema, pallida fra la nebbia, si copriva spesso di nuvole fuligginose; l’aria n’era allora spaventevolmente cupa: quello che vorrei chiamare, appunto, nerodiluna” (La piccola Apocalisse). Il sole nero dell’antica melancholia è qui trasferito alla luna, ma l’effetto non è uno sconvolgente stato di vuoto e di implacabile tedio, quanto piuttosto un’ironica familiarizzazione del lontano lunare, e allo stesso tempo un onirico disorientamento. Fatti, questi, che fanno pensare ancora al modello leopardiano che presiede a questa rappresentazione: la nebbia, la fuliggine e lo spavento sono elementi presenti nel leopardiano Frammento (già Il sogno, poi Lo spavento notturno), in cui Alceta racconta a Melisso un sogno da cui s’è svegliato in preda a un forte turbamento. In quel sogno la luna si staccava dal cielo e cadeva sul prato vomitando nebbia e scintille, sfrigolava come fa il carbone immerso nell’acqua, poi si spegneva levando tutt’intorno un gran fumo, lasciando nel cielo “come un barlume o un’orma, anzi una nicchia”. Certo, in Landolfi può aver agito l’esempio leopardiano della personificazione parodistica e familiare della luna, messa in scena anche nelle Operette con il Dialogo della terra e della luna. Ma possono avere agito anche le tante fantasticherie selenitiche al seguito del viaggio dell’Astolfo ariostesco, sospese tra leggerezza e senso della finitudine, tra umor malinconico e grazia narrativa. O potrebbero non essere estranei al funambolismo landolfiano né il Baudelaire dei due poèmes dedicati alla luna, Tristesses de la lune e La lune offensée né il Laforgue delle lune familiari e “provinciali” e dei Pierrot. Ancora alla leopardiana luna che sfrigola sul prato fa pensare il racconto di Landolfi sul lupo mannaro, nel quale la luna, acchiappata da uno dei due amici, è “un grosso oggetto rotondo simile a una vescica di strutto, ma un po’ più brillante”, pulsa, versa un liquido ialino, poi, chiusa nel camino, sale verso la cappa, scompare nella gola, si fa nera, e infine riesce a liberarsi dalla strettoia e si leva in cielo fuligginosa, finché non si schiarisce con i venti e torna a splendere come prima.
Nella Pietra lunare il rapporto del personaggio femminile con la luna è doppio: sacrale e insieme oscuro, cioè legato a richiami di un mondo sotterraneo animato da revenants e da voci e figure di un altro tempo. La doppia appartenenza alla luce e all’oscuro, all’umano e all’animale, all’intimità e all’estraneità miniaturizzano nelle forme del sentire e nel comportamento di una ragazza il doppio effetto della contemplazione cosmografica, la quale allo stesso tempo sospinge verso un dolce smarrimento nell’oltre e induce il turbamento proprio dell’inafferrabile, e dell’inesplicabile. Se la pietra lunare, in quanto minerale, ha in sé il segno di un’appartenenza perduta, di una celestialità caduta – di cui il mondo ctonio è opaca e sulfurea rappresentazione – essa è allo stesso tempo luminosa relazione con il celeste, con un corpo celeste: da qui l’irradiarsi di una luce che anche nella tempesta è penetrante, luce lunare mineralizzata, che ha i riflessi di tutte le pietre preziose. Nella scena della metamorfosi, quando si scambia l’umano e l’animale, questa luce permane. Da quella luce la bellezza di Gurù è esaltata: “le lunghe ciglia brillavano di minute goccioline, che a momenti la luna accendeva di luce violenta”. E trascorrono nuvole di pece contro la faccia della luna quando appare la capra bianca e nera e si fa prossimo il congiungimento. Poi nella caverna, nella notte della battaglia e del convito, è mostrata davvero la pietra lunare: “Era una scheggia opalescente con vaghi riflessi azzurrognoli, e magari giallognoli o verdastri, come delle creature disformi contro la luna”. Quando la luna tramonta, anche l’esperienza del giovane amico di Gurù, Giovancarlo, svanisce. In quell’esperienza, sotto lo sguardo lunare di una delle Madri, apparse nella luce morente della luna, lo studente-poeta stava per sfiorare l’esperienza di un confine, il confine tra percezione e sogno, tra vigilanza dei sensi e sprofondamento nella visione.
La cosmografia mostra nella Pietra lunare il suo incavo oscuro, e tuttavia, ancora luminoso: è l’esperienza della descensio nella regione dove la bellezza rivela la sua nascosta radice, dove la lingua espone il suo fondamento nella fisica creaturalità vegetale e animale, dove il sentire confina con l’immemoriale, il visibile con l’invisibile, il celestiale con il sotterraneo.
Un cielo nel ventre della terra
Il Landolfi di cui Calvino ha dato un ritratto animato e fervido introducendo l’antologia di racconti Le più belle pagine oscilla tra l’ossessione della forma e l’abbandono al dominio del caso – del caso come ombra del vuoto e della morte –, e ancora tra il fascino dell’esattezza e la postura ironico-disperata di chi sa che nessuna geometria, e nessuna scrittura, può fare da argine all’irrimediabile (irrimediabile, direi, nel senso anche di gnostica lotta nell’abisso del male che dava Baudelaire nel poème L’irrémédiable). Calvino vedeva nella passione di Landolfi per il gioco, per la puntata d’azzardo, la manifestazione esistenziale di questa doppia tensione. Da questo punto di vista la dimensione cosmografica in lui è più che una curiosità: la sua rappresentazione risponde da una parte a una sorta di esorcismo dinanzi all’infigurabile, all’infinito, dall’altra a un tentativo di sporgersi su quella profonda soglia dove la geometria dell’universo si coniuga con l’inconoscibile, le leggi delle ellissi e dei movimenti hanno uno sfondo abissale. La forma, insomma, e l’azzardo. La terra spesso appare a Landolfi come il luogo dove l’uomo non guarda il cielo, non esplora quel che è sopra di lui, ma incontra se stesso attraverso un’apparizione animale che spesso si rappresenta come incubo e ossessione: le labrene o il ragno mostruoso che ha la testa del babbo di Kafka oppure le blatte, che galleggiano sulle acque e presto si rivelano essere un’immensa superficie che stringe la nave, un mare nero come l’inchiostro, che si stende a perdita d’occhio fino all’orizzonte, e impedisce di levare gli occhi al cielo, lingua d’incubo della terrestrità. E anche quando il cielo compare, come appunto in un passaggio del Mar delle blatte, esso è solo “la cappa affocata” che deve far risaltare l’orrore dell’immenso nero che assedia ogni cosa.
Ma nel racconto La tenia mistica il cielo riappare nel cuore della terra, nelle sue cavità profonde. Qualche anno prima che il padre le Coëdic, intorno al 1749, discendesse nelle viscere della terra dove s’era rifugiato il padre Mersenne, fedele cartesiano, con i suoi discepoli, e scoprisse l’origine di tutte le cose, è accaduto anche a Nicholaus Klimius di calarsi in una caverna della Norvegia e di precipitare, rottasi la corda, in certe profondità che si rivelarono essere un pianeta, chiamato Nazar. C’è, intorno a quel pianeta posto al centro della terra, un’aria “chiara come la nostra”, ci sono alberi, c’è un cielo nel quale molti astri compiono “le loro rivoluzioni”, astri “abitati da strumenti musicali, da scimmie, da mostri e portenti d’ogni sorta; gente di strani costumi, eppure, talvolta, singolarmente più ragionevoli dei nostri…”. Al di là del seguito del breve racconto, presentato, con erudito garbo, come apertura per una serie di annotazioni sulla terra in quanto corpo vivente, abitato nel suo ventre da immensi animali, quel che colpisce è la fantasticheria di un cosmo, con il suo cielo, e i suoi astri, che si mostrerebbe contenuto nel cuore della terra. Alle mitografie dell’imbuto infernale abitato dai dannati si oppone l’avventuroso viaggio in un mondo popolato da astri. In uno di questi astri, Mezendor, le piante sono dotate di ragione, i tribunali sono infatti “presieduti e composti da alberi”, e gli animali hanno varie funzioni, “le volpi sono ambasciatori, i corvi esecutori testamentari, i montoni o capri grammatici, i cavalli consoli”. I viaggi di Gulliver, e l’antropologia fantastica che da essi discende, fino a Michaux, qui appaiono con il loro mirabolante spirito che, rovesciando il convenzionale, ricompone un mondo di isole e lingue e pensieri e insomma oppone alla ragione “civile” un’altra ragione, la cui anima è la l’immaginazione, la sua immensa possibilità. Per Landolfi questa cosmografia rovesciata è l’occasione di una nuova antropologia, quel “seno della terra” nel quale “si convolgono astri” rappresenta una fantasticheria non più ossessiva e da incubo: è un respiro dell’interiorità, uno spiraglio affabulatorio e leggero nella gravità della discensio. È solo un cenno, peraltro trattenuto dalla mediazione ironica, dal filtro libresco ed erudito. Ma un cenno può essere un passaggio verso la definizione di una poetica.
Lo spazio celeste come vuoto dell’anima
Cancroregina è allo stesso tempo favola fantascientifica venata di malinconico umore, trattatello che sottopone a gelida ironia le magnifiche sorti di ogni conquista tecnica, racconto filosofico che muove dalla curiosità per l’avventura e finisce con lo svolgersi come amara meditazione sulla fragilità delle difese conoscitive dell’uomo dinanzi alla costante esposizione alla morte. Ed è, ancora, operetta morale che mette in scena il trionfo implacabile dell’oggetto sul suo costruttore, della macchina sul pensiero, del corpo artificiale sul corpo sensibile. È apologo sullo slittamento della ragione umana verso la follia, del viaggio verso il suo rovescio – cioè la negazione di ogni approdo –, della percezione verso il neutro che cancella ogni percezione. Apologo sullo slittamento della vita stessa verso una non-vita che non è ancora morte e della morte verso una non-morte che non è più vita. Landolfi, con Cancroregina, raccoglie tutti le precedenti esplorazioni cosmografiche riunendole in un racconto compatto, la cui scansione ha al centro una tragica cesura: la consapevolezza che la sfera spaziale non potrà mai approdare sulla terra e neppure sulla luna. Dopo l’espulsione nello spazio di Filano, già preda della follia, l’io narrante resta da solo con i congegni, con il suono pulsante della navicella, con la sua ostilità. E scopre che il dilatarsi del tempo sfilaccia la sua stessa misura, si libera da ogni scansione, mima l’eternità, si fa maschera parodica dell’eternità. Così il ragionare del personaggio si inviluppa su di sé, le emozioni si raggelano, l’io si contrae in un estremo barlume di scetticismo mentre prende atto dell’inevitabile destino. Il dialogo con la navicella presto si rivela inceppato, impossibile. Restano soltanto, della sua voce “brontolii fieri e minaccevoli, rantoli, ululati, schianti, traballamenti, squilibri”.
La luna, che la tecnica voleva dimostrare prossima, transitabile, è chiusa, severamente, nella sua irraggiungibilità: anche se a un certo punto l’autore del diario vede (o sogna?) i suoi abitanti, la loro stravagante ibrida composizione. La distanza dalla luna è la distanza dalla terra. In questa doppia disperata e folle distanza si spalanca un pensiero aspro, implacabile, della finitudine, e della vuota appartenenza all’umano, anzi della separazione progressiva da quella appartenenza. A un certo punto, lo sguardo verso la terra provoca un’improvvisa intrusione di nostalgia: “Laggiù c’è la notte, che io non conosco da mesi. E c’è anche il tramonto, coi suoi graduali, coi suoi delicati e ricchi passaggi, con tutti i suoi mille colori, sfumanti l’uno nell’altro; e non soltanto questo bianco e questo nero, i due colori dell’orrore. E c’è un venticello tiepido che risveglia le erbe e i fiori dei campi, le cime degli alberi, che increspa la superficie delle acque. Ci sono gli animali… C’è anche uno, un uomo come tanti (un mio simile!) che si avvia verso casa…”. Ma il proposito di non rimpiangere nulla si riaffaccia, imperioso, e lo sguardo si ritrae dalla terra. Allo stresso modo è anche fugata l’illusione di un qualche smarrimento nella contemplazione cosmica. Non c’è più il punto di vista che dalla lontananza pensava di svuotare la centralità dell’uomo delle sue pretese. Anche la critica dell’antropocentrismo è sottoposta a ironia. La distanza dalla terra è distanza da sé, dal cielo stesso, da tutto.
Quel che resiste è la leggera, ancora funambolica, invenzione d’un racconto che, col suo carico di pensieri e di figure, mostra che la lingua può creare un altro tempo: fragile, perplessa navigazione nel cielo del tempo umano, assediato dalla incontrollabile necessità.
da “Chroniques Italiennes”, n. 81-82, 2008, pp.111-18, a cura di Denis Ferraris.
______________________
AGA MAGÉRA DIFÚRA: SUL TRADURRE DA LINGUE INESISTENTI
Familiarizzare una lingua, renderla comprensibile, trasportarla dalla regione oscura dell’enigma nel paese luminoso del significato è un impulso che rassicura, perché dispone segni misteriosi o suoni privi di senso lungo la linea di una visibilità controllabile. Una lingua cessa di essere fonte di inquietudine, diventa sorgente di curiosità interrogativa e di conoscenza. Diventa tramite, talvolta, per la comprensione di culture e storie e avventure umane rimaste fino a quel momento avvolte in una fredda e lontanissima luce. La stele di Rosetta decifrata da Champollion dilata il sogno di un’approssimazione più certa – per via del conforto offerto dalla scrittura – al senso che presiede alla costruzione delle piramidi o ai tanti fino allora inclassificabili reperti archeologici. La decifrazione di una scrittura favorisce la comprensione di riti, credenze, rapporti di potere, vita quotidiana di un popolo.
Ma questo impulso a tradurre dall’oscuro e dall’ignoto – nella nostra cultura designati di volta in volta con i caratteri di una scrittura, come il geroglifico, o persino col nome stesso di una lingua, come l’arabo o il turco – si estende anche alle lingue di cui si hanno solo rarissime testimonianze o la cui esistenza addirittura non è dimostrata. Quello che Leopardi chiamava “frivolo sogno” –la ricerca, cioè, di una lingua prima, che precede e fonda tutte le lingue, o il restauro a ritroso dell’indoeuropeo, che affannava alcuni filologi nel primo Ottocento – si dilata fino a comprendere lingue misteriose, improbabili, o persino mai esistite. Il sogno qui confina con l’artificio, la ricerca della ricostruzione con l’opera di invenzione ludica. E su questo terreno si incontra il sogno infantile di una lingua propria, esclusiva, che nessuno degli adulti possa comprendere, una lingua a partire dalla quale si può definire e riconoscere una piccola comunità di adepti.
Come nel campo animale c’è una sorta di universale Dizionario di zoologia fantastica – il Manuale proposto a suo tempo da Borges e Guerrero è solo per così dire un visibile passaggio – e narrazioni varie hanno collaborato e collaborano ad allargare, idealmente, i lemmi di questo immenso interminabile lessico, di questo bestiario inesistente ma reso vivente dall’immaginazione (anche chi scrive si è ritenuto in dovere, dal suo modestissimo canto, di partecipare con alcuni racconti a quest’opera di estensione del trasognato bestiario), così da più parti si è collaborato e si collabora alla costruzione di un universale fantastico Dizionario delle lingue inesistenti. Senza dire che davvero esistono cartacei Dizionari di lingue immaginarie (in Italia, ad esempio, ce n’è uno presso Zanichelli, per le cure di Paolo Albani e Berlinghiero Buonarroti) ed esiste, naturalmente, una tradizione considerevole di studi intorno all’invenzione delle lingue e alla ricerca di una lingua unica, alle sue relazioni con il pensiero umano e la civiltà (da Le lingue inventate di Alessandro Bausani, l’islamista traduttore del Corano, di Rumi e di Nezami, al saggio di Umberto Eco La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, per fermarsi all’orizzonte italiano). Ma che si tratti del newspeak di Orwell o delle lingue parlate nelle opere narrative di Asimov, di Tolkien, di Celati, che si tratti di lingue artificiali, sotto la cui definizione vanno comprese le lingue ausiliarie internazionali, le lingue logiche, le lingue sperimentali, le lingue artistiche, insomma tutte le lingue di cui si occupa la cosiddetta esolinguistica, sempre, in ogni caso, si pone la questione del come tradurre la parola della misteriosa lingua in un’altra lingua, ossia in una lingua condivisa da una larga comunità, una lingua che ha una sua storia, una sua cultura, dei suoi parlanti. Tradurre da queste lingue vuol dire da una parte rassicurare il lettore o l’ascoltatore che tutto ha un senso, che ogni voce umana (o galattica, nel caso della fantascienza) è riportabile a un orizzonte di senso, dall’altra che ogni lingua, reale o fantastica, è una tessitura di convenzioni, di artifici, di relazioni tra suono e senso, e la distinzione tra lingue storicamente accertate e lingue immaginarie è assai esile. Tradurre da queste lingue, inoltre, è continuare il gioco dell’invenzione, estendere l’artificio da una lingua supposta originale a una lingua supposta d’arrivo. L’atto stesso del tradurre, come abbiamo visto a proposito degli esempi del giovane Leopardi, appartiene all’esercizio inventivo della scrittura. Ma mentre Leopardi si muoveva, fantasticamente, nel campo delle lingue classiche, dunque tra lingue note e letterariamente strutturate, e in quel campo costruiva testi dicendo d’averli ritrovati (è il caso delle Odae adespotae delle quali egli produce il testo greco e la traduzione latina o il caso dell’Inno a Nettuno, del quale offre la traduzione in versi italiani, in attesa di poter dare al lettore il testo originale criticamente accertato), c’è chi traduce da una lingua che è essa stessa frutto d’invenzione, anche se chi ne parla la cataloga tra lingue lontane e tuttavia conoscibili. È a quest’ordine di narrazioni che appartiene il racconto giovanile – e davvero inaugurale – di Tommaso Landolfi Dialogo dei massimi sistemi, un racconto che comparve nel 1937 in una raccolta dal titolo eponimo e che Calvino nella antologia landolfiana, curata nel 1982 per Rizzoli, riportò nella sezione Le parole e lo scrivere. In questo racconto il narratore riferisce il caso occorso a un suo amico, designato soltanto come Y. Costui s’è trovato ad apprendere, applicandosi molto, il persiano: glielo ha insegnato un sedicente capitano inglese, conosciuto in una trattoria, che di tale lingua s’è detto sicuro conoscitore e che dopo il ciclo di lezioni è tornato nella sua terra. Con le parole di questa lingua persiana, ormai per lui non più misteriosa e anzi addirittura già parlata con disinvoltura, l’amico Y dopo lunghi esercizi ha composto, con grande ardore, tre poesie. Ma confrontando un giorno le tre poesie con la lingua di un vero poeta persiano, e dopo aver consultato grammatiche e crestomazie persiane, l’autore deve constatare di non avere appreso affatto il persiano ma una lingua del tutto inesistente, ed è appunto in quella lingua inesistente che ha scritto le sue poesie. Dopo altre verifiche, egli esclude anche l’ipotesi d’avere magari appreso comunque un persiano ma affidato a una grafia immaginaria. Chi sta raccontando la storia conduce l’autore delle poesie da un famoso critico il quale in un’animata e patafisica conversazione persuade Y del valore estetico dei suoi versi, anche se scritti in una lingua inesistente: questo perché solo chi detiene la conoscenza di una lingua può dei suoi testi giudicare e in questo caso il solo interprete ed eventuale dispensatore di gloria letteraria è appunto l’autore stesso, il signor Y. È nel corso dell’incontro col grande critico che una delle poesie viene letta dal suo autore e da lui stesso tradotta, “improvvisando sul testo”.
Riporto qui, mentre invito il lettore ad andare a leggersi il bel racconto di Landolfi, solo i primi tre versi che nel falso persiano suonano:
Aga magéra difúra natun gua mesciún
Sánit suggérnis soe-wáli trussán garigúr
Gùnga bandúra kuttávol jeris-ni gillâra.
La traduzione che l’amico Y fornisce suona invece:
Anche piangeva della felicità la faccia stanca
Mentre la donna mi raccontava della sua vita
E mi affermava il suo affetto fraterno.
I due testi poetici raffrontati – quello preteso originale e quello tradotto dallo stesso autore seduta stante – hanno sì delle corrispondenze di fonesi, di accentuazioni, hanno alcune intese vocaliche, ma al martellante e grave rispondersi dell’ultima sillaba di ogni verso nel testo originale – fatto che strappa al critico in ascolto il commento di un “pas mal, proprio pas mal” – la traduzione non replica con altrettanta dispiegata energia sonora. Le forti assonanze e le rime in úr e quelle conclusive in úsc del primo testo si perdono nella traduzione, e il lettore si trova di fatto dinanzi a due testi lontani tra di loro, privi di alcun legame, corrispondenti solo nel numero (undici restano i versi tradotti). Tale distanza è paradossale se si pensa che dell’uno e dell’altro testo, dell’originale e della traduzione uno solo è l’autore: quasi a voler dire che la traduzione è davvero altro – altra lingua, altra catena di suoni, persino altro senso – dall’originale. Anche quando traduzione e originale hanno lo stesso autore. Il fatto è che la traduzione da una lingua immaginaria è anch’essa nell’ordine dell’invenzione: lingua del primo testo e lingua del testo tradotto sono due momenti della stessa azione, due passaggi della stessa narrazione.
Ma se nella traduzione da “lingue inventate” il traduttore resta nello spazio fantastico del primo testo, e in certo modo ne prosegue il gioco inventivo, altra è la condizione di chi traduce da scritture fondate su quella che chiamiamo “invenzione linguistica”. Il traduttore ha davanti, in questo caso, testi o passaggi di testi in cui la lingua è materia per così dire prima del narrare, o del poetare, ed è per questo sottoposta a deformazioni, contaminazioni con altre lingue, sovrapposizioni, ibridismi, contrazioni, duplicazioni consonantiche o vocaliche, rafforzamenti, abbreviazioni, inserzioni di frammenti provenienti da lingue diverse, inversioni, modulazioni fonosimboliche e molte altre operazioni designate con l’espressione di sperimentalismo linguistico.
Se tradurre da idiomi derivati dall’ibridazione di lingue appartenenti a popolazioni diverse, come è il caso del pidgin dei Caraibi o dell’Oceania, implica la scelta di cancellare, nella lingua d’arrivo, proprio il riverbero di quella pluralità linguistica e culturale che traluce nella scrittura, tradurre da testi nei quali la sperimentazione linguistica è dominante, o comunque è sostanza stessa della scrittura, significa accettare in partenza un esito per dir così riduttivo o appianante. A meno che non ci si avventuri in un lavoro in grado di ricostruire – in parallelo e quasi a specchio – forme che nella nuova lingua restituiscano, in tutti i particolari, o almeno il più possibile, l’ardimento e le venature di quel primo sperimentare. Questa condizione – che ha in opere come Finnegans Wake di Joyce uno degli scogli più ardui – è anche quella di chi si trovi a dover tradurre calembour, giochi di parole, filastrocche, gerghi di gruppi, argot d’epoche diverse, forme anagrammatiche o lipogrammatiche, o anche tutte quelle forme in cui la dominanza del suono ha una funzione rilevante, oltre che una fascinazione, irrinunciabile.
da A. PRETE, All’ombra dell’altra lingua. Per una poetica della traduzione, Bollati-Boringhieri, Torino 2011, pp. 71-76.
______________________
DRAMMATURGIA DEL MELANCONICO. INTORNO ALLA SCRITTURA DI TOMMASO LANDOLFI
Theatrum mundi e cosmografie
La scrittura di Landolfi accoglie dalle poetiche romantiche la tensione metafisica e insieme grottesca, l’affabulazione ironica e insieme perturbante, ma mette in scena allo stesso tempo una barocca considerazione del mondo come un gran teatro, dell’esistenza come un immenso palcoscenico, dell’umana avventura come una commedia dai colpi di scena imprevedibili. Colpi di scena sorvegliati da un indecifrabile intreccio tra caos e caso, tra destino e necessità, tra perversità della logica, potremmo aggiungere, e logica della perversità (a questo intreccio naturalmente non è estraneo il “demone della perversità” di Poe, e neppure l’altro demone, quel demone dell’analogia che Mallarmé vede misteriosamente operare nel cuore del linguaggio, della sua rappresentazione scenica e poetica).
Di questo theatrum mundi non è la vanitas che risuona in Landolfi né il rovinare di scettri e corone, non il Trauerspiel, dunque, né la meditazione sull’insignificanza delle umane glorie, ma la passione cosmografica. Una passione che controlla lo stupore con l’ironia, lo smarrimento con l’artificio verbale, la tensione fantasticante con la parodia. Ed è qui – in questa misura che si fa stile e modo descrittivo – il rapporto di Landolfi con le leopardiane Operette morali, con il loro teatro filosofico, con la loro animazione cosmografica. Dal Dialogo della Terra e della Luna al Dialogo di Ercole e Atlante al Copernico, la lingua scenica delle Operette disloca il punto d’osservazione dell’umano in una lontananza estrema, mette in scena una miniatura del cosmo, sfalda ogni residuo antropocentrismo e riconduce gli elementi astrali a figure di un teatrino grottesco, irridente e insieme metafisico. L’effetto per dir così morale di questo teatro filosofico è che lo spazio della finitudine mostra quel suo confine inattingibile e tuttavia fonte di inquieta investigazione che è l’infinito. È a questo leopardiano orizzonte che la scrittura di Landolfi fa riferimento, un riferimento anche consapevole, è questa eredità che già in Pietra lunare si mostra, con le sue variazioni e reinterpretazioni e reinvenzioni, naturalmente. Da qui il giudizio del Signor Giacomo Leopardi messo in scena, con una filosofica mimesi di scrittura, in appendice a Pietra lunare. Racconto, questo, “straordinario” – secondo una novecentesca ripresa del romanzesco straordinario – dove la sovranità pensosa e sfingica e amicale della luna leopardiana è portata da una parte verso la terrestrità corporea dell’amore e allo stesso tempo animalizzata e resa sotterranea, ctonia, pur restando, ancora leopardianamente, allo stesso tempo divina e familiare, lontanissima e prossima, teofanica e quotidiana.
[…]
Si tratta, ogni volta, di una cosmografia la cui rappresentazione ha i caratteri teatrali dell’azione scenica, con l’artificio di fondali dipinti, e anche di parodiata maniera, con la ricerca di elementi visivi che possano alludere, anche per opposizione, a quell’infigurabile che è l’infinito. Così, nel racconto La tenia mistica, il cielo riappare nel ventre della terra e si apre un cosmo nel quale “si convolgono astri”. Un’altra descensio, di natura teatrale e costruita su materiali di citazione. Penso a quando De Chirico riprende il vecchio commento figurativo ai Calligrammes di Apollinaire per riproporre, in Sole sul cavalletto, del 1973, un teatrino che ha per fondale un paesaggio dipinto: sul campo celeste ci sono un sole nero dalla lunga raggiera e una falce di luna anch’essa nera, dal sole parte un filo che collega l’astro con il suo simile giallo posto su un cavalletto, dalla gobba lunare parte un filo che va verso la falce deposta sulle assi del pavimento. Così gli emblemi della antica e moderna Melancholia – sole nero, luna nera – sono riportati nello spazio scenico di un’oggettività priva ormai di ogni emozione dinanzi al cosmico. La lontananza è ricondotta nello spazio di una miniaturizzazione e familiarizzazione ludica. Anche il Landolfi di Cancroregina persegue, con la navicella e con le emozioni e i pensieri ricondotti nel chiuso dell’abitacolo, una scenica riduzione dello spazio cosmico, un teatro diremmo metafisico nel quale fare agire, nella finzione narrativa, il rapporto umano con la lontananza e con l’estremo come rapporto mediato e schermato dalla parodia, dall’artificio. Certo, Cancroregina è anche altro, è trattatello che sottopone a ironia le sorti della tecnica, operetta morale che fa trionfare l’oggetto sul costruttore, la macchina sul pensiero, apologo che fa scivolare il viaggio verso il suo rovescio, cioè verso la negazione dell’approdo, la vita verso una non-vita, il tempo verso una mimesi artificiosa dell’eternità. Ma la distanza dalla terra e dalla luna riconduce tutto – pensieri, scrittura diaristica, sguardo sulla terra lontana ed evocazione dei suoi colori, del suo venticello, delle sue albe – nella misura pulsante e insieme inceppata della macchina volante. Cioè in un chiuso teatro, in un interno ossessivo e quasi beckettiano dal quale muovono risonanze che sono interrogazioni sul senso del vivente in relazione allo spazio e al tempo, sul senso dell’esistenza del singolo in relazione al ritmo del cosmo.
Rifrazioni da una stanza
La pulsione teatrale di Landolfi è certo leggibile nella costruzione di situazioni sceniche di interni, dalle quali si rifrange un pensiero dell’estremo e dell’orrore. Si pensi al chiuso, appunto kafkiano, della stanza nel racconto Il babbo di Kafka o alla parete su cui compaiono le labrene o alla stanza in cui pervertimento e amore si congiungono nel bacio di quello “sconcio capezzolo rientrato” (in Un petto di donna), o anche alle sale in cui prende vita la misteriosa spada. Una sequenza di interni inquietanti che rinviano, certo, alle stanze del castello di Pico, ma che sono anche la costruzione visiva di un luogo dove i fantasmi dell’interiorità prendono forma, lingua, figura. Ma quella pulsione teatrale segue anche la via opposta, cioè trasforma l’aperto in una situazione definita, circoscritta, con l’effetto appunto dell’artificio teatrale, sicché persino il mare che l’invasione delle blatte rende come un inchiostro – “il mare a perdita di vista, senza una terra all’orizzonte” – a un certo punto si mostra come il fondale teatrale su cui si gioca la commedia dell’assurdo e dell’orrore. E anche le narrazioni che inscenano iperlogiche conferenze, che mimano impervie e causidiche trattatistiche, che espongono mirabolanti lezioni ad allievi abulici e tuttavia incalzanti, le narrazioni che danno forma e ritmo al gioco della lingua, alle inesauribili risorse e al tesoro della lingua, che danno vita e animazione e animalizzazione alla lingua, si svolgono nel tempo e nello spazio di una situazione teatrale. Sicché, se un lettore volesse in questi casi tentare un passaggio dalla scrittura narrativa alla scrittura teatrale non sarebbe cosa difficile, essendo già implicita nella forma racconto, così come Landolfi la pratica, una sorta di tecnica teatrale. Se non si tratta, come accade talvolta, addirittura di didascalie da copione e di appunti di scena usati come materiali della tecnica narrativa (si veda Rotta e disfacimento dell’esercito o anche, per le parentesi che indicano gesti dei personaggi, La morte del Re di Francia). Insomma l’immaginazione teatrale non è in Landolfi separabile dalla tecnica narrativa, è un suo elemento e forse una fonte stessa del romanzesco, del suo svolgimento. Né poteva essere ininfluente l’esperienza della traduzione dei russi, da Lermontov a Puskin, per i quali spazio teatrale e spazio narrativo (e anche spazio poetico, potremmo aggiungere) si compenetrano e sovrappongono, il personaggio ha nel suo movimento, nell’espressione monologante e dialogante dei suoi pensieri posture teatrali e, per altro verso, il teatro stesso è spesso una narrazione figurata, un racconto messo in azione. Dal teatro Landolfi riprende la tecnica di costruzione temporale, la struttura dell’azione mascherata, del fraintendimento, dell’equivoco, ma anche il finale disvelamento. E, spesso, queste tecniche teatrali hanno sul fondo una loro metafisica trasvalutazione, un rinvio insomma al theatrum mundi, come accade in Ottavio di Saint-Vincent che nel finale raccoglie l’eco della lunga teatralizzzazione della vanitas, da Sofocle a Shakespeare: “Addio, signora. Ah, come non vedete che noi tutti veniamo dalla stessa noia e andiamo verso lo stesso nulla”. Del resto è proprio per questa contiguità tra esperienza narrativa ed esperienza teatrale che Landolfi a un certo punto affiderà in modo esplicito alla forma teatro le sue metafisiche fantasticherie. Per questa contiguità tra narrazione e teatro, sullo sfondo di una clownesca e malinconica concezione della scena del mondo, delle sue maschere, il rinvio a certi racconti di Arturo Loria appare motivato. Del resto, non si può non invocare, ad avvalorare la relazione tra i due, la condivisa attenzione a quella commistione di caso e fatalità con cui si mostra, indecifrata e indecifrabile, l’esistenza dei singoli. Nello splendido racconto di Loria Il Falco sentiamo annunciato quell’intreccio tra teatro della crudeltà e grottesco, tra artificio e assurdo che sarà anche di Landolfi.
La voce, le voci
La voce, il registro delle sue tonalità e rifrazioni e risonanze, è quel che unisce narrazione e teatro della parola. In Landolfi la voce è quel che dà timbro e persino unità al racconto. E si tratta, come dice Calvino, di “una voce che pare faccia il verso a un’altra voce (ma come un grande attore che per definire un personaggio non ha bisogno di distaccarsi che appena un tantino dalla propria dizione abituale”). È per questa implicita teatralità vocale, per questa attorale impostazione, che lo stesso Calvino definirà, più oltre, il narrare di Landolfi come uno “spettacolo verbale che sa dosare i propri colpi di scena con precisione, ma anche abbandonarsi agli estri più volubili”. In questo sbalzo lieve tra la propria voce abituale – propria nel senso dell’io narrante, non dell’autore – e la voce del personaggio è giocata la tecnica di uno straniamento particolare, sottile, appena percettibile, costantemente in bilico tra distanza del personaggio dal narratore e intromissione del narratore, della sua voce, nella vicenda e nel tono stesso del personaggio. A questo scarto tra voce narrante e voce del personaggio va aggiunto lo scarto tra voce narrante e voce di colui che scrive: come diceva il Barthes semiotico del racconto, “colui che parla (nel racconto) non è colui che scrive (nella vita) e colui che scrive non è colui che è”. Ma è nel ventaglio svariatissimo di toni dello stesso registro ironico-discorsivo che sta l’abilità di Landolfi. Entrano in scena una dopo l’altra, nella mente del lettore, queste voci con i loro toni: dalla voce monologante dell’abulico e stralunato e perverso signorino di provincia in Maria Giuseppa, rivolto a un pubblico di ascoltatori (“In fede, rido a pensarlo, Signori”) alla voce che racconta, ne La moglie di Gogol, i modi tenuti nell’ottenere ogni volta il tipo di donna desiderato. O ancora dalle voci, ogni volta variate, dell’amico Y nel Dialogo dei massimi sistemi alla voce del conferenziere che svolge in Foglio volante considerazioni sulla civiltà fino alla voce che intrattiene l’uditorio con una lezione sulle cose che non sono (Un concetto astruso). Del monologo Landolfi sperimenta tutte le modulazioni, ed è il monologo che permette all’autore di cambiare maschera scenica, di esibire posture diverse di narratore, di accedere al tripudio insieme logico e fantasioso della lingua, ai suoi lessici incantatori e tumultuanti. È, direi, nell’energia multiforme e metamorfica del monologo l’attitudine teatrale precipua di Landolfi. Laddove il narratore arretra fuori scena perché il rilievo sia dell’azione, dell’accadimento, della situazione eccezionale o imprevista e della tensione narrativa (caratteristiche che definiscono per Cortázar la vera natura del racconto breve), è alla forma dialogica che è affidato il gioco delle voci e delle loro tonalità e la stessa struttura teatrale della narrazione. Il notturno di una buia stanza di passaggio accoglie le voci sussurranti di Marta e Lorenzo, in Ombre, mentre intorno volteggiano e s’affacciano finti fantasmi. E nelle Labrene l’intrattenimento amoroso di Adalberto e di sua cugina Enrichetta, da poco supposta vedova, in presenza del marito di costei, morto apparente che ascolta, dà alle voci risonanze beffarde, prima che, tornato a vita, sia lo stesso marito, con le sue ossessioni, a fare lentamente sfumare quel dialogo nelle nebbie del sospetto, del dubbio, dell’irrealtà, secondo un crescendo pirandelliano. Oppure il dialogo corteggia i modi dell’assurdo, come accade nel racconto Pioggia dove la moglie coinvolge il marito nella ricostruzione del proprio sogno, pretendendo che anche lui, il marito, abbia sognato il suo stesso sogno. E ci sono voci, come accade in Teatrino, che non sopportano altre presenze se non quelle dialoganti sulla scena – sulla scena del racconto, della vita – e non hanno bisogno si nessuna altra voce narrante. A queste voci portate narrativamente sulla scena bisognerebbe opporre (o affiancare?) la voce di Landolfi autore di diari e di versi, dove nello scarto tra l’io scrivente e l’io autobiografico si depositano umori, interrogazioni, investigazioni, cioè modi della ricerca di sé tendenti, tutti, non tanto a separare il moi même dal livre, il sé dal gioco della scrittura, quanto a cercare una via d’uscita dal teatro per dir così di scena. Per un teatro dove il demone dell’analogia e della perversità, il colpo di dadi e l’azzardo non ricorrano più alla mediazione di personaggi e di voci straniate, ma osservino in faccia l’esistenza, sapendo di non potere sfuggire alla sua implacabile necessità, sapendo che all’esistenza non si può opporre il nulla, ma forse solo ancora, fino all’estremo, la parola. Una parola-confessione. Che il vero teatro del melanconico sia la confessione?
Intervento al Convegno indetto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze sul “Teatro di Tommaso Landolfi” (Firenze, 12 dicembre 2008).
______________________
LUNA NERA
“Bene dixisti de me, Thoma”: l’ironico calco tomistico, messo in bocca alla Luna e rivolto all’autore, seguito da un secondo esergo che cita Novalis, indicano già, ad apertura de La pietra lunare, le due forme di una presenza nella scrittura: da una parte la luna osservata nella sua ambivalenza – divina e familiare, lontanissima e prossima, enigmatica e domestica, sovrana e intima –, dall’altra la luna come figurazione attiva, e in certo senso emblema stesso, del notturno romantico, genere ripreso nella sua componente abissale, ctonia, perturbante, e sottoposto a un trattamento ironico.
La luna di Landolfi non è la luna leopardiana. Non riprende quasi mai gli attributi con i quali il recanatese ha corteggiato, evocato e interrogato la luna (candida, amica, ignuda, rugiadosa, tacita, muta, silenziosa, cadente, peregrina, queta, placida, cara, pensosa, graziosa, vergine, intatta, immortale, benigna, eterna, dominatrice, de le notti reina, ecc., per non dire degli attributi che accompagnano il raggio lunare o che definiscono la luce lunare). Non è, come in Leopardi il pulchra ut luna del Cantico dei Cantici a improntare la relazione tra il lunare e il femminile. L’apparizione della luna non annuncia, come accade nella poesia leopardiana, il teatro di un’interiorità turbata da cui muove, quasi sempre, la ricordanza, e neppure dispiega l’interrogazione dell’oltrelimite, dell’infinito, oltrelimite e infinito che hanno nella luna, sfinge e tuttavia confidente, la loro abbagliante soglia.
Eppure un costante dialogo con la luna leopardiana anima la scrittura “lunare” di Landolfi: esegesi leopardiana in forma narrante, controcanto, commento e replica. E la tessitura poetica della narrazione – di cui ha detto Zanzotto introducendo La pietra lunare – deve a questo dialogo con Leopardi i colori del suo ventaglio: tra affabulazione e parodia, tra modi fantastici e ansia metafisica (per questo il giudizio del Signor Giacomo Leopardi è messo in scena, con una splendida e filosofica mimesi di scrittura, in appendice al racconto del ’37).
La sovranità pensosa e amicale e enigmatica della luna leopardiana nella Pietra lunare è per così dire umanizzata e insieme animalizzata, cioè è portata sulla terra, nella terrestrità corporea dell’amore. Gurù non è soltanto una creatura lunare, che si muove in relazione costante con il sorgere e tramontare della luna. È, come in un teatro gnostico, emanazione corporea della divinità lunare, quasi suo eone o angelo, ma è anche figura della compresenza di luce e oscurità che è propria della luna. Come la luce lunare, la sua apparizione avviene in una “lenta oscurità luminosa”. Il suo discorrere, come la maschera lunare, è seduttivo, imperioso; rivela, mostra le cose nella notte, nomina forre e erbe, piante e dirupi, cespugli e grotte portando ogni cosa verso la luce, e allo stesso tempo quel che nomina lo nasconde nell’impenetrabile, nell’onirico, nell’impossibile. Il suo dire, accompagnando Giovancarlo sul monte e nella tempesta, svaria di intensità perdendosi nell’indecifrabile. Così i suoi gesti. Il suo viso pare riflettere quella luce nell’ombra e quell’ombra nella luce di cui dice Leonardo nel Trattato della pittura, a proposito dei visi che stanno sull’uscio, sulla soglia delle case. E sulla soglia dell’insondabile, dell’oscuro, è sempre Gurù, ma offerta allo stesso tempo alla vista, al piacere della vista. Gurù appare in un’ora lunare che è il corrispettivo rovesciato dell’ora meridiana: abolire il confine tra luce e ombra comporta nell’ora meridiana (si pensi al Fauno di Mallarmé) il vacillare del confine tra realtà e illusione, e comporta, nella notte lunare di Landolfi, lo sconfinamento del visibile nell’enigma, del luminoso nell’oscuro, del dicibile nell’inesplicabile. La scrittura del fantastico, da Poe a Hoffmann a Gautier a Dostoevskij a Maupassant, per citare un angolo della biblioteca landolfiana, s’è sempre mossa in questa regione dove una costante metamorfosi è in atto: l’incredibile si mostra come credibile, l’estraneo come familiare, il misterioso come quotidiano. Il freudiano Unheimliche ne può raccontare il movimento interiore, ma il complesso arabesco che tesse la scrittura non si consegna tutto all’indagine analitica, affonda nella singolarità dello scrittore, nel suo stile, nella sua invenzione.
La sovranità della luce lunare, quando si impone su lontane fantastiche regioni – L’impero della luna nel Principe infelice – avvolge le cose, prive dei contorni, in un bagliore di diamanti che è come nebbia: l’acqua pare d’alabastro, ogni scintillio è irreale, i vestiti sono ghiacci, inzuppati della vitrea luce lunare, malinconici sono gli abitanti, malati di chiardiluna. Se la luce lunare è, come i fiori del male, “maladive”, mortale può invece essere un’altra luce, quella del sole che, fugando nel giorno ogni residuo “fuoco d’ombra”, confondendo anch’esso i contorni delle cose, acceca col suo fulgore l’uccello della notte, la civetta, che via via lungo il dilagare della luce s’è chiusa in sé, sbigottita. È il bellissimo racconto Colpo di sole, in cui l’avvento del giorno, il suo dispiegarsi che dissipa velature e accende falde e addensa barbagli è descritto dal punto di “vista” – e di sopravvenuta cecità – della civetta, la quale dalla nausea e dalla malinconia muove verso una dolente, abbagliata oscurità, finché non “sprofonda nella luce bianca della morte”.
La luna, di volta in volta gelida, ingenua, beffarda, spettrale, sbocconcellata, rugginosa, sorgente di un’indecifrata luminosità, ha un legame sotterraneo, analogico, con il volto femminile. Dalla Pietra lunare fino a uno degli elzeviri pubblicati sul “Corriere della sera” (La luna, le piene), questo rapporto oscilla tra la metamorfosi e l’incarnazione. Gli occhi di Gurù, luminosi nella notte, e la fanciulla “bianca di Luna” di cui si racconta nel succitato elzeviro hanno il subitaneo fulgore e il legame tra familiare e misterioso proprio di un’apparizione che agita la memoria e discopre l’onda increspata di un rammemorare torbido. Nel secondo racconto è proprio la terra obliosa dell’infanzia ad essere smossa dalla notturna apparizione femminile e lunare.
Il volto visibile, e splendente, della luna, s’irraggia sulla superficie del mondo, incarnandosi nella sua bellezza, con tutto il tremore e l’incantamento che la bellezza provoca, ma il volto nascosto della luna presiede invece al “rovescio delle cose”, a ciò che, inatteso, contraddice i nostri pensieri, intorbida le nostre attese. L’altra faccia della luna scompiglia l’ordine temporale delle cose, la scansione ordinata delle ore e degli eventi. Dar di volta alla luna: l’espressione risale, dice Landolfi, all’ “avviso di quell’antico astronomo che stimava essere la faccia della luna cava (egli anzi inferiva che ciò sarebbe servito un giorno alle potenze celesti per incenerirci, rivolgendosi l’astro su se stesso e ardendo a mo’ di specchio ustorio l’intero nostro globo)”. Il lato fantastico dell’analogia qui prende campo assorbendo nel titolo – Voltaluna – l’intero svolgersi dell’altro quotidiano lato.
Se l’altra faccia della luna, stando all’antico astronomo, è cava, la faccia esposta alla terra può mostrarsi offuscata, imbrattata, annerita. Ecco un passaggio de La piccola Apocalisse: “Una luna scema, pallida fra la nebbia, si copriva spesso di nuvole fuligginose; l’aria n’era allora spaventevolmente cupa: quello che vorrei chiamare, appunto, nerodiluna”. Il potere del sole nero che talvolta solcava il cielo degli antichi, la sua terrestre proiezione nell’umor nero, nella classica melancholia, sono trasferiti alla luna. La traslazione non è solo d’atmosfera. Eppure la luna nera di Landolfi non indugia nei cieli dell’anima, non attrae a sé, alla sua cifra, simbolicamente, la condizione umana. È piuttosto, leopardianamente, affabulazione del lontano, trattamento ironico dell’incanto, che s’accampa nelle pagine del narratore secondo un procedimento teatrale: e si tratta, si capisce, di un teatro su cui s’affaccia, di tra le quinte, il tumultuante enigma dell’esistenza. L’esempio leopardiano qui è attivo.
Nel leopardiano Frammento (già Il sogno, poi Lo spavento notturno) Alceta racconta a Melisso un sogno da cui s’è svegliato in preda a un fortissimo turbamento: la luna si stacca dal cielo e cade sul prato vomitando nebbia e scintille e sfrigola come carbone vivo che s’immerga nell’acqua, poi si spegne e si annera levando tutt’intorno un gran fumo, lasciando nel cielo “come un barlume o un’orma, anzi una nicchia”. Incantamento rovesciato e frantumato, miniaturizzazione grottesca dell’elemento cosmico, ma anche tremore per l’assenza, per la privazione. La caduta della luna come figura onirica e poetica del vuoto, della mancanza. Inoltre il Dialogo della terra e della luna, nelle Operette, dove agisce il modello di Luciano, fa della familiarizzazione e dell’addomesticamento parodistico del mito lo spazio scenico per una critica dell’antropocentrismo. Oltre all’esempio leopardiano, in Landolfi sono attivi altri esempi di seleniti che hanno avvicinato la luna con la lente parodica e allo stesso tempo malinconica, sia che seguendo Astolfo abbiano viaggiato verso il satellite sia che abbiano danzato, funambolescamente, e poeticamente, nella luce lunare, sul filo teso tra finitudine e leggerezza: dal Baudelaire dei due poèmes dedicati alla luna, Tristesses de la lune e La lune offensée fino alle lune familiari e “provinciali” di Laforgue e dei suoi Pierrot.
In particolare alla leopardiana luna che sfrigola sul prato fa pensare il racconto landolfiano del lupo mannaro, che comincia esponendo il conflitto lunare dei due personaggi: “L’amico ed io non possiamo patire la luna: al suo lume escono i morti sfigurati dalle tombe, particolarmente donne avvolte in bianchi sudari…”. La luna, acchiappata dall’amico è “un grosso oggetto rotondo simile a una vescica di strutto, ma un po’ più brillante”, pulsa, versa un liquido ialino, è percorsa da deboli correnti sottopelle. Chiusa nel camino sale verso la cappa e sparisce nella gola, s’annera tutta, poi si libera e si leva in cielo fuligginosa, infine lentamente si schiarisce con i venti e torna al suo primitivo splendore, a sconforto e pena dei due lupi mannari. La caduta della luna, il suo immiserimento nella domesticità, è un episodio di illusorio dominio dell’uomo, l’abbagliante biancore della luna e la sua lontananza tornano a trionfare nel cielo.
Se il lupo mannaro è descritto nel risibile tentativo della cancellazione lunare, la capra mannara Gurù è descritta nella sua relazione eroticamente sacrale con la luna, con la natura e il mondo animale, nella sua doppia appartenenza alla luce e all’oscuro, alla bellezza e al sotterraneo mondo di una storia fattasi coro di volti e voci e alterchi e sfide. Il lunare della Pietra lunare ha la sua essenza nella terra, nelle sue cavità, che accolgono fantasmi e revenants, mentre il lunare di Cancroregina ha il suo elemento nell’aria, nella sospensione aerea, nella lontananza che la macchina volante non può più accorciare.
Il paesaggio della Pietra lunare, mentre è penetrato da una luce lunare per così dire mineralizzata – argento, giada, topazio, alabastro, opale sono le pietre che prestano gli attributi più frequenti – espone il suo aspetto rupestre, scomposto. La terra, flagellata dalla tempesta di vento e di pioggia, va preparando il teatro per l’evento metamorfico. La luce lunare attraversa la tempesta, la bellezza di Gurù ne è esaltata: “le lunghe ciglia brillavano di minute goccioline, che a momenti la luna accendeva di luce violenta”. Corrono nuvole di pece contro la faccia della luna quando appare la capra bianca e nera e si fa prossimo il congiungimento, che è metamorfosi, scambio dell’umano e dell’animale. Si apre il tempo della discesa nella caverna, tra i briganti, dove le parole nel buio possono però essere di luce. Nella notte della battaglia e del convito, è mostrata la pietra lunare: “Era una scheggia opalescente con vaghi riflessi azzurrognoli, e magari giallognoli o verdastri, come delle creature disformi contro la luna”. La luminosa Gurù nella caverna e tra i briganti ricorda la bellezza abbagliante di Esmeralda in Notre Dame de Paris, i suoi legami col mondo umano sotterraneo. Dopo la discesa nel profondo, ecco, ancora nella notte, l’apparizione delle Madri (le faustiane Madri), “immobili d’orrida immobilità”, messaggere di un gelido mondo, gli occhi “assorti, argentati come canapa” che fissano la luna. Uno sguardo d’ombra, della stessa natura dell’ombra lunare che copre nell’eclisse il sole, uno sguardo che impietra cose e creature. Lo sguardo lunare di una delle Madri sospinge Giovancarlo verso la soglia, ancora corporea e sensibile, dell’ibridazione panica, dell’esperienza suprema di un passaggio sul confine tra corpo e natura, tra percezione e sogno. Poi il tramonto della luna, e le creature diafane si ritirano dalla scena. “Cade la luna; e si scolora il mondo”: il verso leopardiano sembra qui commentato in chiave parossistica, espressionista, sulfurea. Il racconto di Landolfi può essere letto come una splendida variazione del notturno lunare romantico, che dà forma e presenza ai fantasmi del sentire. Il giovane Giovancarlo è il poeta che fa esperienza della descensio di là dalla soglia diurna della percezione, sospingendosi in quella regione dove la bellezza mostra il suo fondamento oscuro (il fiore del male), la parola rivela la sua radice, cioè la fisica creaturalità vegetale e animale, il sentimento mostra la sua contiguità con l’onirico, con l’immemoriale, con l’invisibile.
In Cancroregina, il racconto del 1950, la luna, che la tecnica vuole mostrare prossima, transitabile, è chiusa, severamente, nella sua irraggiungibilità. Anche se a un certo punto l’autore del diario estremo vede (o sogna?) i suoi abitanti, la loro stravagante ibrida composizione. La distanza della luna è la distanza della terra. In questa doppia, disperata e folle distanza, si dischiude il pensiero della finitudine, e della vuota appartenenza all’umano. Visti dallo spazio il sole ha il colore del ferro arroventato, la luna e la terra hanno “una violenta, aggressiva, eppur gessosa luminosità”. Se in Pietra lunare la luna scende sulla terra con i suoi misteriosi poteri, in Cancroregina ogni sogno di ascensione – di viaggio letterario nell’oltremondo – è bruciato. Neppure la parodia è più possibile. L’elevazione propria della poesia, lo sguardo dall’alto – degli angeli, degli uccelli, dei poeti – appare nella sua illusorietà. E tuttavia una passione cosmologica spinge la scrittura verso il racconto della lontananza. Come la cosmologia leopardiana cerca una lontananza da cui osservare l’esile confine tra il vivente e il nulla, così la cosmologia landolfiana cerca un punto di lontananza da cui osservare il vuoto delle illusioni, il bizzarro capriccio della tecnica, l’inanità dei sogni, la casualità e inconsistenza degli eventi che designiamo col nome di vita. È davvero l’individuo – la sua ragionevole follia, la sua irragionevole saggezza – l’universo ancora inesplorato.
in Un linguaggio dell’anima, a cura di Idolina Ladolfi e Antonio Prete, “Quaderni del gallo silvestre”, Manni, San Cesario di Lecce 2006, pp.85-92.