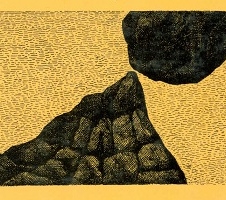Landolfi inventore di lingue
di PAOLO ALBANI
1. Non fa meraviglia che uno scrittore come Tommaso Landolfi si sia cimentato nell’invenzione di lingue considerando che ha allestito il suo personalissimo stile ponendo grande attenzione al linguaggio, preso tra il mascheramento di una lingua alta ottocentesca del tutto letteraria e un tono discorsivo basso che rimanda al parlato (apparente dicotomia messa in luce da Gianfranco Contini che definì Landolfi un «ottocentista eccentrico in ritardo»), con un uso originale e suggestivo di letterarismi, arcaismi, toscanismi, neoformazioni e particolari allomorfi(1).
Il bernoccolo dell’inventore di lingue lo scrittore di Pico, da sempre ossessionato da una sorta di religioso e superstizioso amore e terrore delle parole(2), lo ha sviluppato fin da ragazzo quando si arrovellò, votato all’insuccesso, a foggiare una lingua personale, una lingua vera e propria con tutte le sue regole; per fare ciò, ricorda Landolfi, «dovevo rifarmi da ancor più lontano, ossia inventare in primo luogo un paese, un popolo, una sua storia e così via, la lingua essendo il supremo fiore anzi frutto d’una civiltà; empii fogli e fogli, che ogni tanto ritrovo. E forse questo mi si configurò nel capo come la ricerca di un’altra cosa»(3).
2. L’esempio più fantasioso di lingua inesistente elaborata da Landolfi si ritrova al suo esordio narrativo, ovvero nel racconto Dialogo dei massimi sistemi (1937)(4) dove il protagonista – indicato semplicemente come signor Y – discute sul valore estetico di alcune poesie scritte in una lingua inventata, che solo lui (ma forse neanche) può capire. Il signor Y ha appreso da un capitano inglese il «persiano» con cui scrive tre componimenti. In seguito, però, scopre che la lingua imparata non è il «persiano», e nemmeno «lo jakuto o una lingua haino o l’ottentotto», ma una lingua che non esiste. Non sapendo come interpretare le sue poesie, il signor Y si rivolge a un grande critico, «uno di quegli uomini per i quali l’estetica non ha segreti e sulle spalle dei quali riposa in pace la vita spirituale» (probabile allusione a Benedetto Croce) e gli legge con voce trepidante questo testo composto di bizzarri segni rassomiglianti a caratteri amarici e tibetani, testo che il grande critico commenta con un «pas mal, proprio pas mal»:
Aga magéra difúra natun gua mesciún
Sánit guggérnis soe‑wáli trussán garigúr
Gùnga bandúra kuttávol jeris‑ni gillára.
Lávi girréscen suttérer lunabinitúr
Guesc ittanóben katir ma ernáuba gadún
Vára jesckilla sittáranar gund misagúr,
Táher chibill garanóbeven lixta mahára
Gaj musasciár guen divrés kóes jenabinitúr
Sòe guadrapútmijen lòeb sierrakár masasciúsc
Sámm‑jab dovár‑jab miguélcia gassúta mihúsc
Sciú munu lússutjunáscru gurúlka varúsc.
la cui traduzione, fornita dallo stesso Y, è la seguente:
Anche piangeva della felicità la faccia stanca
Mentre la donna mi raccontava della sua vita
E mi affermava il suo affetto fraterno.
E i pini e i larici del viale graziosamente incurvati
Sullo sfondo del tramonto rosa‑caldo
E di una villetta che inalberava la bandiera nazionale,
Parevano il viso solcato d’una donna che non s’èra accorta
D’aver il naso lucido. E quel lucido guizzo
Per me molto tempo ancora, beffardo e pungente,
Sentii saltellare e contorcersi come un pesciolino pagliaccio
In fondo alle tenebre della mia anima.
La traduzione libera, si lagna Y, non rende neppure lontanamente l’originale; una volta tradotta, la poesia è irriconoscibile e priva di ogni senso. La discussione che si accende fra il grande critico e Y, autore delle incomprensibili poesie, porta a concludere che un artista è libero di mettere insieme le sue parole (come Aga magéra difúra eccetera eccetera) prima ancora di attribuire loro un senso; del resto il significato non è indispensabile dato che una poesia può anche non avere alcun senso, può essere fatta solo di suggestione musicale; nello scrivere poesie si può partire dal suono di parole suggestive e oscure anziché dall’idea (sembra di sentire Manganelli quando afferma di credere che le parole siano certamente un suono, ma di non essere sicuro che abbiano anche un significato) e suggerire a centomila lettori centomila cose differenti; l’importante è che sia un’opera d’arte la quale «può prescindere non solo dalle convenzioni linguistiche, ma da tutte le convenzioni, ed è unica misura a se stessa». Si sente qui, come hanno rilevato alcuni critici, l’eco di certe teorizzazioni delle avanguardie storiche.
Al termine del Dialogo dei massimi sistemi il narratore c’informa che al signore Y il cervello ha dato leggermente di volta (il matto è una figura ricorrente nella letteratura di Landolfi): «egli si ostina a portare in giro per le redazioni delle strane poesie senza capo né coda, pretendendone pubblicazione e compenso: tutti lo conoscono ormai, e lo mettono senz’altre cerimonie alla porta».
Prima di spendere due parole sul tema della natura di questa lingua immaginaria di Landolfi, una curiosità: una storia simile a quella raccontata da Landolfi nel Dialogo dei massimi sistemi sembra sia accaduta realmente in India verso la fine della seconda guerra mondiale. Un maharajah desidera far apprendere il francese al figlio e assume allo scopo uno studioso di passaggio. Quest’ultimo passa due anni presso la corte del maharajah e insegna la lingua al suo allievo. Poi scompare. Quando il figlio del maharajah si reca a Parigi scopre che nessuno lo comprende e che la lingua da lui appresa è una lingua sconosciuta(5).
Su alcune astruse e misteriose lingue immaginarie, come ad esempio quelle inventate da Rabelais nel Gargantua et Pantagruel, esistono studi approfonditi; uno di questi si deve a Émile Pons che, analizzando «les “jargons” de Panurge», sottolinea alcune possibili derivazioni delle parole coniate da Rabelais nel suo divertimento linguistico dall’antico ebraico o dall’arabo (nel linguaggio degli Antipodi, ad esempio, l’espressione ringuam albaras sembra rimandare a linguam ara[l]bas) arrivando in certi casi a formulare una plausibile traduzione in francese(6).
Studi specifici, come quello di Pons, sulla poesia in finto persiano di Landolfi non esistono per quanto ci risulta. Si trovano solo dei cenni. Lo stesso Landolfi, nel racconto in questione, si limita, per bocca del personaggio Y, a sottolineare la presenza delle u negli ultimi versi e le rime in usc. Le rime rispondono a uno schema preciso (ABCB ABCB DDD), scrive Rodolfo Sacchettini; la poesia somiglia a un sonetto «mancante» perché privo dell’ultima terzina. Ogni parola ha una terminazione ben definita (-era, -it, -ernis, -an, -ur, -is, -ara, -avi, -escen, -esc, -er, -ir, -es, -u, -ut, -usc, -or, -und…) e tutte, escluso quelle in rima, hanno una terminazione che ricorda una declinazione latina, greca, tedesca o di lingue orientali(7).
Secondo Daniele Baglioni lo pseudopersiano di Landolfi ricorda una lingua mediorientale per la presenza congiunta delle consonanti h e eh e degli pseudoarabismi mesciún, wáli, katír, gadún, jesckilla, misagúr, táher, mahára, musasciár, masasciúsc e mihúsc, costruiti su modelli morfologici simili a quelli semitici. Se si osservano le terminazioni delle parole, s’individuano alcuni elementi ricorrenti, come –úr, –úra, –ún, -en, -ára e –úsc, nei quali è facile individuare dei morfemi. Alcuni di essi presentano sempre la stessa consonante con una vocale variabile (ad esempio magéra, difúra, gillára, oppure garigúr, musasciôr, sierrakár), ciò potrebbe far pensare all’esistenza di regole di alternanza morfofonologica. Ben quattro volte negli undici versi del componimento compare il trattino (soe-wáli, jerís-ni, sámm-jab e dovár-jab): in quest’ultimo caso potrebbe avere valore morfologico, congiungendo la radice alla desinenza dell’infinito, dato che gli unici elementi grammaticali che si ripetono nella traduzione sono i due infiniti saltellare e contorcersi. Ma le corrispondenze, afferma Baglioni, non sempre funzionano: Landolfi si diverte a giocare col lettore, premiandolo e deludendolo di volta in volta. Sarebbe vano ad esempio cercare la parola che significa donna nell’originale, ripetuta due volte nella traduzione, così come impossibile è individuare il termine che sta per lucido, presente anch’esso due volte, o i pronomi personali mi e suo/sua(8).
Dal 1928 al 1932 Landolfi studia all’Università di Firenze dove probabilmente segue le lezioni di glottologia di Giacomo Devoto e Carlo Battisti; traduce in quattro lingue (russo, francese, tedesco e spagnolo) e ne conosce altre fra cui l’arabo e il giapponese. Questo, in breve, a testimoniare della sua competenza linguistica che certo gli permette in più occasioni di indossare, divertito, i panni dell’onomaturgo. Per altro è un appassionato lettore di Jonathan Swift, grande inventore di lingue fittizie nei Viaggi di Gulliver. Che Landolfi abbia una certa familiarità con le lingue immaginarie si desume inoltre, fra le altre cose, dal racconto «La tenia mistica», apparso ne La Spada (1942), dove sono riportate le parole inventate – «spik autri flok skak mak tabu mihalatti» – che Niel Klim, esimio baccelliere, ascolta sul pianeta Nazar; l’esempio è ripreso con qualche minima variazione dal romanzo utopistico-allegorico Il viaggio sotterraneo di Niels Klim (1741) di Ludvig Holberg. Nel testo di Holberg, per altro non citato da Landolfi, le parole esatte in nazarico o «lingua sotterranea», contenute nel libro Delle calunnie, sono: «Spik. antri. Flak. Skak. mak. Tabu. Mihalatti Silac»(9).
3. Un altro esempio di lingua inventata da Landolfi compare sul numero 3 di Letteratura del luglio-settembre 1941, in un articolo intitolato «Qualche notizia sull’L.I.», in seguito ripubblicato sul Corriere della Sera del 14 agosto 1978 con varianti di carattere soprattutto formale e con il titolo redazionale «Volete imparare questo alfabeto?»(10). Ennesima parodia (uno «“scherzo” in “parafrasi”» l’ha chiamata Sanguineti), in questo caso della Linguistica, in forma di breve trattato, genere così caro a Landolfi(11).
Dopo aver premesso che le notizie sul Landolfiano, un linguaggio strutturato in tre versioni contrassegnate rispettivamente «L.I, L.II e L.III», sono desunte da un vasto trattato rimasto incompiuto a opera di un amico defunto, Landolfi offre una dettagliata descrizione di questa curiosa lingua. I generi sono quattro: maschile, femminile, neutro e astratto, mentre i numeri sette: singolare, duale, triale, decale, centale, miliale e milionale (quest’ultimo sostituisce il nostro plurale). Il sistema è molto chiaro: le quantità intermedie sono caratterizzate dal numero immediatamente inferiore, salvo il caso dei multipli di 2, 3, 10, 100, 1000 e 1 milione. I casi ammontano a 146, di cui solo 125 dotati di desinenza caratteristica, e sono esattamente il doppio dei complementi, cosa che si spiega con il fatto che ogni complemento ha due aspetti, l’astratto e il concreto. Il verbo ha diciotto aspetti, nove concreti e nove astratti ossia: il lentivo, il rapidivo, il buttivo o improvvisivo, il gioivo, il tristivo, l’egualivo, il prossimivo, il lungivo, l’egualivo spaziale. Questa impostazione flessiva, precisa Landolfi, assorbe senza residui «gli incoativi e i futurivi propriamente detti delle nostre lingue indoeuropee». Ogni tempo presenta tante persone per quanti sono i numeri. Tra i molteplici ausiliari, si trovano i due verbi morire e nascere, usati nella costruzione detta del conativo all’infinito. Le coniugazioni sono 1200. Ogni verbo inoltre può essere transitivo o intransitivo. Aggettivi, pronomi, articoli, preposizioni sono tutti declinabili e seguono per quanto riguarda genere, numero e caso, il sostantivo cui si riferiscono. Nessuna parte del discorso ha un posto fisso nella struttura della frase. Dal punto di vista del sistema di notazione grafica il Landolfiano può definirsi un sistema semi-ideografico comprendente una serie di ideogrammi (ognuno corrispondente a un radicale) e una serie di diacritici a valore alfabetico. Gli ideogrammi sono 118.000, ma non è escluso, scrive Landolfi, che altri ne vengano alla luce una volta rintracciate le carte 428-702 dell’Archivio di Praga, rapite alla fine del secolo scorso. L’alfabeto del Landolfiano comprende 381 segni che formano 1524 lettere dato che il loro valore muta secondo la posizione (in alto, in basso, a destra o a sinistra della cosiddetta base). La scrittura del Landolfiano è bustrofedica in quanto un testo si legge da destra a sinistra, e viceversa alternativamente, sempre in senso orizzontale e cominciando dal basso. Per consuetudine nei testi stampati un quadratino delimita il campo di ogni cosiddetta base, mentre un quadrato più ampio intorno al primo assicura lo spazio necessario ai diacritici. Rivolto al lettore, Landolfi conclude il suo scritto con queste considerazioni: «Ahimè lettore, mio lettore, stavolta, su queste precise parole il manoscritto del mio povero amico è rimasto interrotto, verso la pagina numero… beh, non voglio spaventarti. Ma forse è nato chi lo continuerà. Resterebbe verbigrazia ad occuparsi ex novo della fonetica, aspetto assai complicato e dibattuto della faccenda. Spero a buon conto, quando farò passare le schede di sottoscrizione per l’impresa che ho in animo e di cui ho detto in principio, di poter contare sulla tua adesione».
4. Per concludere un cenno a un ulteriore linguaggio atipico usato da Landolfi nel racconto «Nuove rivelazioni della psiche umana. L’uomo di Mannheim» (uscito ne La spada). Non si tratta di un vero e proprio linguaggio inventato, ma di un sistema tiptostenografico dove ogni lettera è espressa da piccoli colpi. In una nota iniziale Landolfi avverte, per risparmiare agli eventuali critici una delle loro numerose preoccupazioni (leggi: di fare brutte figure come fece quel sopracciò della critica letteraria rotocalcica che scambiò per inventate le parole de La passeggiata) e per dovere d’onestà, che il racconto è una parafrasi della parte seconda di un testo di William Mackenzie (1877-1970), biologo, filosofo e parapsicologo inglese, nato e vissuto per lo più in Italia, docente di filosofia biologica all’Università di Genova dal 1939 al 1945(12).
Negli anni 1912-1913, insieme a altri scienziati, Mackenzie studiò il caso dei «cavalli calcolatori e pensanti di Elberfeld» e quello di un terrier scozzese di tre anni di nome Rolf, passato alla storia col nome di «cane ragionante» poiché la bestiola, addestrata dalla sua padrone, la signora Moekel di Mannheim, era in grado di contare e rispondere a domande complesse.
Gli studi di Mackenzie avevano il fine di dimostrare l’intelligenza animale. Nel suo racconto Landolfi rovescia la situazione e riporta una relazione letta alla Reale Accademia delle Scienze dall’on. Onisammot Iflodnal, arzebeigiano (scienziato che ritroviamo anche nei racconti «Da: “L’astronomia esposta al popolo”. Nozioni d’astronomia sideronebulare» in Il Mar delle Blatte e altre storie, 1939, e «Da: “La melotecnica esposta al popolo”» in La spada, 1942), tesa a dimostrare a tutti i cani che abbiano la mente sgombra da atavici pregiudizi l’intelligenza umana prendendo spunto dalle sedute condotte con il celebre «Uomo di Mannheim» il cui nome è Tommy o Tom.
Molti degli esempi usati da Landolfi sono tratti dal testo di Mackenzie, sono dunque in tedesco e tengono conto per quanto riguarda i colpi la frequenza relativa delle consonanti (le vocali non sono usate) nella lingua tedesca.
L’alfabeto del cane Rolf, come pure quello dell’«Uomo di Mannheim», è:
a b c d e/ei f g h i k l m n o
4 7 24 9 10 1 11 12 13 14 5 8 6 2
p q r s t u v w x z
15 25 3 16 17 18 20 19 21 23
e si completa con altri segni:
2 = sì 3 = no 4 = stanco 5 = strada (bisogni)
Naturalmente là dove nel testo di Mackenzie, quando alla domanda «Chi è questo?» rivolta a Rolf mostrandogli la figura di un cane bassotto, Rolf risponde «cane bassotto» e quando alla successiva domanda viene chiesto a Rolf se anche lui è un cane bassotto, Rolf risponde «Cane», nel racconto di Landolfi l’Uomo di Mannheim, cioè Tommy, alla domanda se lui è un cane bassotto, risponde ovviamente: «Mann (uomo)».
Le conclusioni cui giunge lo scienziato Iflodnal, dopo le sue sedute con Tommy, è che, al pari dei cani, anche l’uomo sente, pensa e comunica le proprie idee, e dunque i cani dovranno riconoscere nell’uomo il proprio simile.
Nella «Nota dell’editore», premessa al testo di Mackenzie, Angelo Fortunato Formíggini si chiedeva, a proposito degli studi sull’intelligenza animale, se queste meraviglie «resteranno isolate, senza seguito, e non se ne parlerà più in avvenire», oppure se apriranno «un nuovo orizzonte al sapere umano?» Certo Formíggini non poteva prevedere che di lì a pochi anni a parlarne di nuovo, a modo suo, sarebbe stato lo scienziato Iflodnal, appassionato estensore di una serie di singolari piccoli trattati.
NOTE
(1) MAURIZIO DARDANO, Sulla lingua di Tommaso Landolfi, in Cento anni di Landolfi, a cura di SILVANA CIRILLO, Bulzoni, Roma, 2010, pp. 43-71.
(2) TOMMASO LANDOLFI, Prefigurazioni: Prato, in Le più belle pagine scelte da Italo Calvino, Rizzoli, Milano, 1989, pp. 296-304.
(3) ID., Des mois, Rizzoli, Milano, 1991, p. 3.
(4) ID., Dialogo dei massimi sistemi, in Dialogo dei massimi sistemi, Adelphi, Milano, 1996, pp. 73-92. Uscito nel 1937 nell’omonima raccolta di racconti, il testo di Landolfi nel manoscritto, datato «Roma. 23 III 1935 (seduta unica)», è intitolato Un problema estetico e le sue conseguenze.
(5) L’episodio è narrato in GUY BECHTEL, JEAN CLAUDE CARRIÈRE, Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement. Le livre des bizarres, Laffont, Paris, 1991, p. 641.
(6) ÉMILE PONS, Les “jargons” de Panurge dans Rabelais. Les langues imaginaires dans le voyage utopique, «Revue de Littérature Comparée», 2, XI, avril-juin 1931, pp. 185-218.
(7) RODOLFO SACCHETTINI, La lingua “impossibile” della Piccola Apocalisse, «Chroniques italiennes», 81-82, 2008, pp. 119-38.
(8) DANIELE BAGLIONI, Lingue inventate e nonsense nella letteratura italiana del Novecento, in «Nominativi fritti e mappamondi». Il nonsense nella letteratura italiana. Atti del Convegno di Cassino 9-10 ottobre 2007, a cura di GIUSEPPE ANTONELLI e CARLA CHIUMMO, Salerno Editrice, Roma, 2009, pp. 269-87.
(9) LUDVIG HOLBERG, Il viaggio sotterraneo di Niels Klim, a cura di BRUNO BERNI, Adelphi, Milano, 1994, pp. 53-54.
(10) Ora anche in LANDOLFI, Diario perpetuo. Elzeviri 1967-1978, a cura di GIOVANNI MACCARI, Adelphi, Milano, 2012, pp. 348-53.
(11) Nella ripartizione in sezioni tematiche con cui Italo Calvino presenta il meglio dell’opera landolfiana (Le più belle pagine scelte da Italo Calvino, Rizzoli, Milano, 1989), insieme alle sezioni dedicate ai RACCONTI FANTASTICI, RACCONTI OSSESSIVI, RACCONTI DELL’ORRIDO, TRA AUTOBIOGRAFIA E INVENZIONE, L’AMORE E IL NULLA, LE PAROLE E LO SCRIVERE, ce n’è una dedicata per l’appunto ai PICCOLI TRATTATI.
(12) Il testo di Mackenzie cui si riferisce Landolfi è Il cane di Mannheim, seconda parte di Nuove rivelazioni della psiche animale, A. F. Formíggini, Editore in Genova, 1914, pp. 115-227.