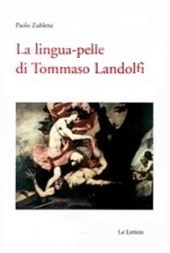Recensione a Paolo Zublena, “La lingua-pelle di Tommaso Landolfi”
Di seguito si propone la recensione al libro di Paolo Zublena, La lingua-pelle di Tommaso Landolfi (Firenze, Le Lettere, 2013, pp. 125), scritta da Daniele Visentini e apparsa su «La rassegna della letteratura italiana», CXVIII, 1, gennaio-giugno 2014, pp. 345-46.
La lingua, sfinge che incanta l’intera opera narrativa landolfiana, palese chimera inseguita durante la stesura dei diari, è soggetto fondamentale alla decifrazione del “personaggio” e dell’uomo Landolfi. Non solo e non tanto la lingua in falsetto, artata, manierata, e come tale studiata nel cavo di ogni sua piega allo scopo di realizzare una prosa unica per accuratezza e complessità di vocabolario, bensì una lingua più concretamente falsa; una lingua «falsamente classicheggiante, falsamente nervosa, falsamente sostenuta, falsamente abbandonata»: falsa in tutti i sensi, dunque falsa per vocazione (LA BIERE DU PECHEUR, in Opere I (1937-1959), a c. di Idolina Landolfi, Milano, Rizzoli, 1991, p. 650). Dove all’aggettivo in questione non si fornisse un mero significato negativo – che d’altronde testimonia lo sfumare del dilemma in tragedia, posto che alla scrittura, come alla vita, un’armonizzazione tra forma e contenuto non possa imporsi –, si scoprirebbe però, all’origine della falsità, la finzione. E, infine, se il risvolto esterno della poiesis, della creazione, coincide necessariamente con la finzione, va da sé che la falsità della scrittura è prigione da cui non si evade, e che anzi costituisce sì un limite all’espansione dello spirito poetico, ma come un’entità che nel contempo preserva e incarcera.
Nel nuovo libro di Paolo Zublena appare evidente sin dal titolo la volontà d’intendere la lingua di Tommaso Landolfi, in un tempo, come limite e come valico – d’intenderla, cioè, non solamente alla stregua di un veicolo di senso, né solo come vacuolo contenitivo che ai margini di quel senso s’impone. Il significato più innovativo dall’analogia tra l’io e la pelle, nell’originaria teorizzazione di Anzieu, risiede nell’impossibilità di separare la funzione disgiuntiva e quella comunicativa della coscienza individuale: l’io perciò va concepito come manifestazione fisica, palpabile dell’unità del sentimento corporeo. Proprio come l’Io-pelle, la lingua-pelle landolfiana è una superficie che nutre la sostanza isolandola, e infine fa tutt’uno con essa – «la motiva e la innerva» (p. 7).
Quella tentata da Zublena nei cinque saggi che compongono il volume potrebbe essere definita alla stregua di una semeiotica landolfiana, nel momento in cui mira, mediante l’analisi scrupolosa della lingua-pelle, a decrittare i sintomi che sopraggiungono al contatto di una coscienza profonda con l’ambiente esterno all’io: vale a dire con il mondo sensato, con le logiche condivise della comunicazione.
Non è per caso che l’autore sottolinea la centralità, nell’economia del volume, del saggio dedicato alla lettura di Rien va: nel secondo diario di Landolfi, infatti, la lingua costruisce «una pellicola per certi versi anche più spessa rispetto al passato» (p. 33), poiché ad essa è affidato il compito di sfilacciare e ricucire di continuo l’idea, l’oggetto della speculazione di volta in volta declinato all’urgenza di sperimentare il soggetto di essa – il sé, inteso però come rovescio implicito dell’altro. Si tratta di una sperimentazione in cui s’insinua l’illuminazione violenta del paradosso: se altrove, e specialmente nelle prime prose narrative (dal Dialogo dei massimi sistemi a La Spada) la scoperta finzione serve a Landolfi per insinuare verità ulteriori che, in quanto tali, sarebbero precluse a qualsiasi forma di confessione schietta, in Rien va il processo è quello inverso che pretende d’ingegnare la verità, di programmare la parola sincera, fino al punto di svelarne ogni minimo ingranaggio retorico. Tenendo presenti da subito questi assunti, Zublena concentra la propria attenzione sulla materia viva della lingua, per tornare poi a esiti di lettura tutt’altro che trasognati, pregiudiziali, idealizzanti o, al contrario, specialistici all’eccesso, come hanno invece rischiato e rischiano di fare le letture landolfiane fondate su astrazioni tematiche, su tentativi di storicizzazione e contestualizzazione fuori asse (l’asse, s’intende, costituito dalla lingua pensante di Landolfi), o ancora sulla delimitazione forzata del “genere”.
Di fatto, ancor più che per la soluzione della lingua-pelle – certamente calzante, e però forse riferibile alla scrittura tout court, se s’intendesse quest’ultima come non passibile di oggettivazioni assolute e contemporaneamente, come vuole Landolfi stesso, mai del tutto sincera o privata –, il merito di Zublena risiede nell’assoluta centralità che egli conferisce al dato linguistico, ai fini della comprensione globale del testo. Nel caso specifico di Rien va lo studioso, mediante un accurato vaglio dei costrutti fraseologici, delle occorrenze terminologiche, della sintassi, delle citazioni inserite a testo, riesce a individuare il forte dualismo presente non soltanto nel diario: l’armonioso contrasto tra maniera (la preservazione della lingua-pelle) e disarmata sincerità (che costituisce un’aggressione alla stessa) si modella su dicotomie ataviche, come quelle tra scrittura e mondo, tra realtà e idea, tra costruzione e distruzione, tra libere contraddizioni e logica logorante, che vanno a comporre forse i soli temi, per quanto vastissimi, dell’opera di Landolfi.
Una prospettiva simile nasce anche dal commento a un testo strettamente legato a Rien va, quel Landolfo VI di Benevento che Tommaso Landolfi, durante la stesura del diario, si accingeva a completare. Di questa tragedia d’argomento storico Zublena fornisce una mappatura accurata, come si farebbe studiando, neo dopo neo, i caratteri sempre unici e delicati dell’epidermide umana per assicurarsi dello stato di salute del corpo. La tunica pellicea, quella scorza difensiva che segna ab origine la peculiarità assoluta dell’uomo rispetto alle altre forme di vita terrestri, qui coincide perfettamente con la capacità di tradurre il pensiero in parola, la parola in ragione e, agli estremi, la ragione in mondo. La lingua del Landolfo, in sostanza, manifesta l’impossibilità, per l’uomo, di recuperare il proprio spirito istintivo e vitalistico mediante la verbalità. Il mezzo trascelto per denunciare il paradosso di un’umanità nel contempo parlante e desiderosa di vita è, ironicamente, un mezzo paradossale: una lingua, cioè, manierata all’eccesso, un monstrum stilistico vero e proprio (p. 63), cui tuttavia è affidato il compito di annunciare il messaggio più sincero che Landolfi abbia mai affidato alla pagina scritta. Solo dopo aver inviluppato se stesso, a suo schermo, in un pastiche linguistico inaudito di arcaismi, di continue citazioni, d’impalcature retoriche desuete, ecco allora che Landolfo (per Landolfi) riesce a dire l’indicibile: i pensieri, i canti dei poeti, e insomma ogni singola parola, se tradotta in realtà, non può che «isvanire […] / come fumo nell’aria senza traccia» (cfr. Landolfi, Landolfo VI di Benevento, in Opere I, cit., p. 945). In altri termini, solo la parola scritta, forse, se liberata dal costante tentativo di rivolgersi alla realtà, può riuscire nell’impresa tragica di custodire l’idea.
Appurato ciò, e se è vero che la parola sta alla lingua come l’accidente alla sostanza, Zublena, penetrando la pelle, arriva davvero a toccare il punto nevralgico del corpus landolfiano. E si noti: quello compiuto nell’arco del libro non si riduce mai a giustificazione, a quadratura forzata di un intero percorso letterario; è, al contrario, l’espressione di singoli indizi di lettura, retta da un puntuale scrutinio dei testi. Quello che Landolfi sembra dirci, tramite l’evocazione operata dal libro, è che l’«umbratile istmo […] tra la vita e la morte» (p. 129), lo specchio in cui si osserva, capovolta, tutta la vita che alle nostre spalle si compone e si muove, altro non è che il riverbero di una parola sospeso sul bordo sdrucciolevole degli eventi. Eppure in questo riverbero, ad ascoltarlo attentamente, c’è tutto il senso che occorre per dirsi vivi.
daniele visentini